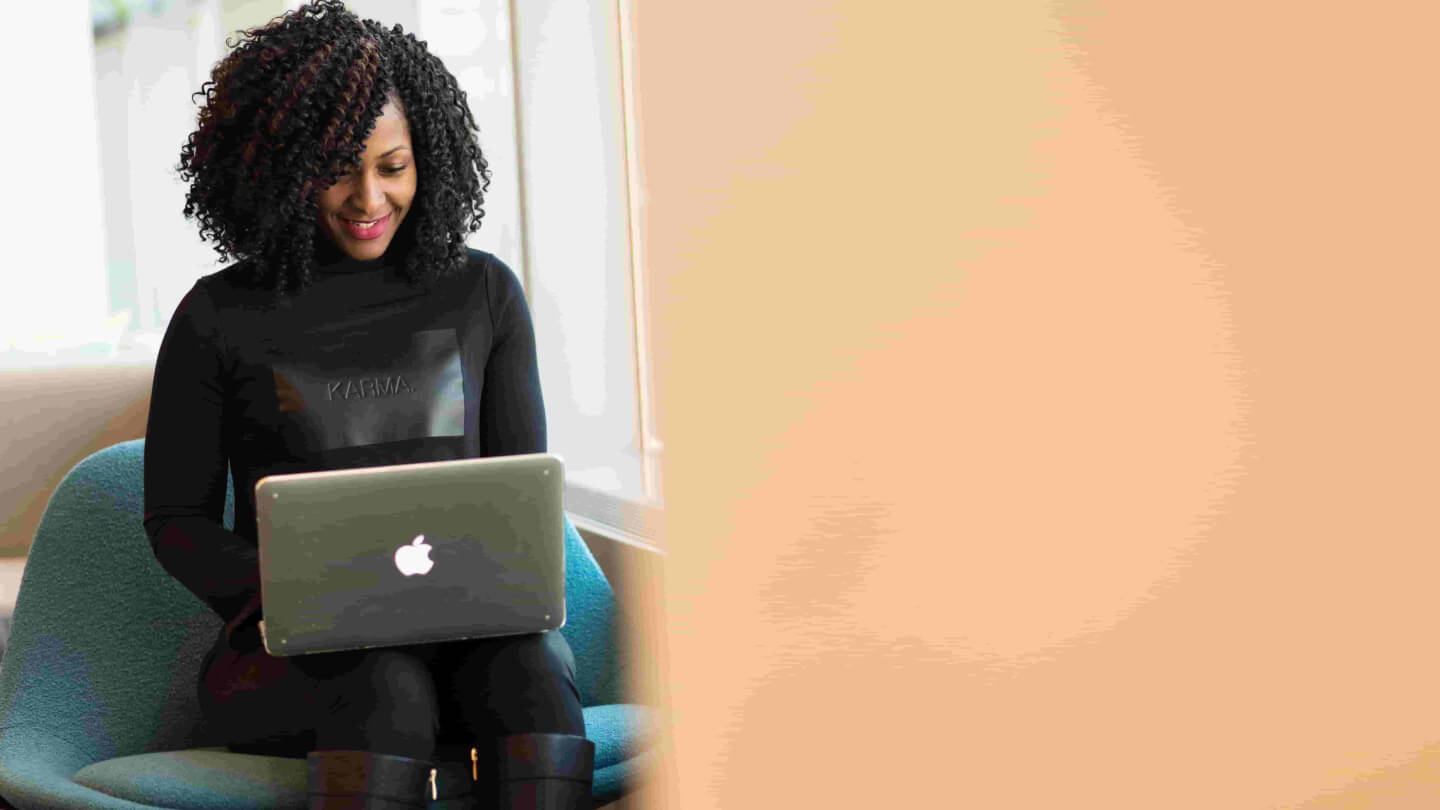Avere successo e, al tempo stesso, sentirsi un bluff. Raggiungere un obiettivo importante e pensare: "Non me lo merito, sono solo stato fortunato". Se queste sensazioni ti suonano familiari, potresti avere a che fare con la sindrome dell'impostore.
È un fenomeno psicologico molto più comune di quanto si pensi, che porta a non percepire le proprie reali competenze e a vivere con la costante paura di essere "smascherati", nonostante le evidenze dimostrino il contrario.
Spesso, chi vive questa condizione si trova proprio all'apice della carriera o in un momento di crescita, ma dentro di sé risuonano pensieri come:
- "Mi sento incapace al lavoro"
- "Prima o poi capiranno che non so fare il mio lavoro"
- "Ho una costante paura di non essere all'altezza".
In questo articolo esploreremo insieme che cos'è la sindrome dell'impostore, perché si manifesta e come possiamo imparare a gestirla per iniziare a riconoscere il nostro reale valore.

Sindrome dell'impostore: cos'è e perché non sei un bluff
Approfondiamo che cos'è la sindrome dell'impostore: si tratta di una condizione psicologica, strettamente legata a una bassa autostima, in cui la persona dubita costantemente delle proprie competenze e fatica a interiorizzare i propri successi. Ogni traguardo, anziché essere percepito come un merito, viene attribuito a fattori esterni come la fortuna, il caso o l'aiuto altrui.
È importante sottolineare che, sebbene possa provocare un notevole disagio, non si tratta di un disturbo mentale. Le psicologhe Clance e Imes, che la descrissero per la prima volta nel 1978, parlano infatti di fenomeno dell'impostore: una costellazione di pensieri svalutanti che influenza la percezione di sé, il rapporto con i colleghi e la serenità sul posto di lavoro.
Curiosamente, questa condizione è l'esatto opposto dell'effetto Dunning-Kruger, la distorsione cognitiva teorizzata dagli omonimi psicologi, secondo cui persone incompetenti tendono a sovrastimare le proprie abilità. La sindrome dell'impostore e l'effetto Dunning-Kruger possono essere considerate, quindi, come due facce della stessa medaglia della percezione di sé.
Il paradosso della sindrome dell'impostore
Può sembrare un controsenso: persone di successo, competenti e stimate, che intimamente si sentono un bluff. Questo rappresenta il cuore del paradosso della sindrome dell'impostore. Più si raggiungono traguardi, più cresce la paura di essere "smascherati".
Il meccanismo si alimenta perché ogni successo non viene interiorizzato come prova della propria abilità, ma viene attribuito a fattori esterni come la fortuna, l'aiuto di altri, o il fatto di aver ingannato chi ci ha valutato. Invece di rafforzare l'autostima, ogni vittoria aumenta la pressione e l'ansia di dover mantenere uno standard che si crede di non meritare, intrappolando la persona in un circolo vizioso di dubbi e insicurezze.
Quali sono le cause della sindrome dell'impostore?
Le cause della sindrome dell'impostore raramente sono riconducibili a un singolo fattore, ma a un intreccio complesso di esperienze personali e contesto sociale. Spesso, le radici affondano in dinamiche vissute nell'ambiente familiare durante l'infanzia e l'adolescenza.
Il ruolo relazionale appreso è centrale. Ad esempio, crescere con genitori iperprotettivi, ipercritici o tendenti al controllo, vivere un'eccessiva competizione tra fratelli o trovarsi in un ambiente con alta conflittualità può gettare le basi per una profonda insicurezza. Se le aspettative percepite sono molto alte o, al contrario, molto basse, si può sviluppare la convinzione di non essere mai abbastanza o di non meritare il successo.
Questa mentalità porta a sminuire ogni risultato: ogni volta che l'esperienza dimostra il contrario, la persona può interpretare che sia stato solo un colpo di fortuna o un errore di valutazione altrui. Questo processo mina sistematicamente il senso di autoefficacia, ovvero la fiducia nelle proprie capacità di raggiungere gli obiettivi.
La sindrome dell'impostore in amore
Sebbene si parli spesso di questa sindrome in ambito lavorativo, è importante ricordare che la sindrome dell'impostore può manifestarsi anche in amore e nelle relazioni. In questi casi, la persona può sentirsi indegna dell'affetto del partner, convinta che prima o poi l'altro "scoprirà" chi è veramente e la lascerà. Questo sentimento è spesso alimentato dall'idealizzazione del partner e da una profonda bassa autostima in amore.
Le conseguenze possono essere complesse e portare a vivere una forte ambivalenza emotiva, a sviluppare dinamiche di dipendenza affettiva o ad accontentarsi di relazioni insoddisfacenti, come nel caso del breadcrumbing.
I sintomi della sindrome dell'impostore: come si manifesta
Anche se la sindrome dell'impostore non è un vero e proprio disturbo, i suoi sintomi psicologici possono avere un impatto profondo sul benessere di una persona. Più che di sintomi, potremmo parlare di un insieme di pensieri e comportamenti ricorrenti che alimentano il senso di inadeguatezza.
Queste manifestazioni sono strettamente legate alla propria autostima, come dimostrato da uno studio che ha evidenziato una forte correlazione negativa tra i livelli del fenomeno dell'impostore e i punteggi di autostima (Al Lawati et al., 2025). (https://bmcpsychology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s43045-025-00512-2) Ma quali sono i campanelli d'allarme? Vediamo insieme i pensieri più comuni che caratterizzano chi vive questa condizione.
"Non sono all'altezza"
Il nucleo di questa esperienza è il pensiero persistente e la paura di non essere all'altezza del proprio ruolo. Questo porta a credere di non meritare riconoscimenti, promozioni o qualsiasi forma di successo. A volte, questa paura dell'imperfezione può essere così intensa da sfiorare l'atelofobia.
Di conseguenza, i complimenti vengono respinti o minimizzati e il proprio lavoro sembra sempre sopravvalutato dagli altri, generando un profondo senso di colpevolezza. Questa dinamica può portare a rinunciare all'ambizione e a evitare opportunità di crescita, per paura di non poter sostenere le aspettative.
"Sto ingannando gli altri"
Chi vive la sindrome dell'impostore convive con la costante sensazione di ingannare gli altri e con la fortissima paura di essere smascherati da un momento all'altro. Ogni situazione di valutazione o giudizio, anche informale, può trasformarsi in una fonte di grande ansia. Per questo, si tende a esporsi il meno possibile, sia con i colleghi che, a maggior ragione, con i superiori.
Questa paura può portare a non fare domande per timore di sembrare stupidi, a non esprimere critiche costruttive e a isolarsi socialmente. Si tratta di strategie di evitamento messe in atto per un unico scopo: nascondere quella che si percepisce come la propria, profonda inadeguatezza.
"Non devo sbagliare"
Per compensare la presunta inadeguatezza, si tende a essere estremamente intransigenti verso sé stessi. Questo atteggiamento può facilmente sfociare in una forte stress lavoro correlato e in una vera e propria ansia da prestazione, dove il lavoro diventa il fulcro della vita, con il rischio di scivolare nella sindrome di burnout.
La lotta contro la svalutazione interiore porta spesso ad aumentare il carico di lavoro e ad alzare continuamente gli standard, anche quando non è richiesto. Un segnale tipico è il rimuginio costante: si rimugina sui propri errori, si analizza ogni comportamento in modo ossessivo, sempre alla ricerca di un perfezionismo irraggiungibile. Questo squilibrio finisce per erodere il tempo e le energie dedicate alla vita privata, alle relazioni e agli interessi personali.
Non esistono specifici test sulla sindrome dell'impostore, ma un test sul burnout può aiutare a prendere consapevolezza di alcuni di questi sintomi.
"Il mio collega merita questo lavoro più di me"
Un'altra caratteristica centrale è la tendenza a idealizzare le capacità altrui e, contemporaneamente, a svalutare le proprie. Il confronto con i colleghi è costante e impari: si tende a sovrastimare il loro operato e a minimizzare il proprio, alimentando pensieri come: "Non so fare niente di speciale, loro sono molto più bravi di me, non merito questa posizione". Questo circolo vizioso rafforza il sentimento di inferiorità e la sensazione di essere un impostore.
I cinque tipi di sindrome dell'impostore
La sindrome dell'impostore può manifestarsi in modi diversi. La dottoressa Valerie Young ha identificato cinque profili principali in cui potresti riconoscerti:
- Il perfezionista: si concentra su come viene svolto un compito. Anche un piccolo errore è visto come un fallimento totale. L'asticella è così alta che il successo è raramente soddisfacente.
- L'esperto: sente il bisogno di conoscere ogni singola informazione prima di iniziare un progetto e teme costantemente di essere smascherato come inesperto o non abbastanza competente.
- Il solista: sente di dover fare tutto da solo. Chiedere aiuto è percepito come un segno di debolezza e un'ammissione di fallimento.
- Il genio naturale: crede che la competenza si misuri con la facilità e la velocità. Se deve faticare o impiegare molto tempo per padroneggiare qualcosa, si sente un impostore.
- La super-donna/il super-uomo: si sente inadeguato rispetto ai colleghi e si spinge a lavorare più duramente e più a lungo per compensare, mettendo a rischio il proprio benessere per dimostrare il proprio valore.
Riconoscere queste tendenze è il primo passo per capire che non sei solo e che questi schemi di pensiero possono essere affrontati e modificati.
Le conseguenze della sindrome dell'impostore
Vivere con la costante paura di essere un bluff può avere un impatto significativo sulla vita professionale e personale. Le conseguenze più comuni includono:
- Ansia e stress cronico: la pressione di mantenere una facciata di perfezione è estenuante e può portare a un'ansia costante.
- Burnout: per compensare la presunta inadeguatezza, molte persone lavorano eccessivamente, portando all'esaurimento fisico e mentale.
- Limitazione della carriera: la paura di fallire può portare a evitare nuove sfide, promozioni o opportunità che potrebbero portare a una crescita professionale.
- Procrastinazione: il timore di non essere all'altezza può paralizzare, portando a rimandare compiti importanti.
- Difficoltà a celebrare i successi: ogni traguardo raggiunto non porta gioia, ma solo un temporaneo sollievo dall'ansia, seguito dalla paura della prossima sfida.
Queste conseguenze non solo minano il benessere psicologico, ma possono anche ostacolare la realizzazione del proprio potenziale.
Sindrome dell'impostore nelle donne
Gli stereotipi di genere e le pressioni sociali possono giocare un ruolo significativo nel nutrire la sindrome dell'impostore, in particolare nelle donne. Il contesto culturale e lavorativo, che spesso fatica a garantire pari opportunità di avere un ruolo di leadership o un'equa retribuzione, può infatti amplificare i sentimenti di insicurezza.
Come evidenziato anche dal Global Gender Gap Report 2023, nonostante i progressi, i divari di genere nel mondo del lavoro persistono. Questo contesto può portare a interiorizzare l'idea di dover dimostrare costantemente il proprio valore, alimentando la cosiddetta "sindrome dell'impostora".
Un interessante articolo della Harvard Business Review sposta l'attenzione dall'individuo al sistema, sostenendo che etichettare questa esperienza come un problema individuale significa ignorare i contesti storici e culturali che la favoriscono. Invece di "riparare" le donne, le autrici suggeriscono di agire sui bias cognitivi e sulle culture lavorative tossiche, che promuovono l'individualismo e il superlavoro.
"Consideriamo i luoghi di lavoro inclusivi come un multivitaminico in grado di garantire che le donne [...] possano prosperare. Piuttosto che concentrarsi sulla correzione della sindrome dell'impostore, i professionisti le cui identità sono state emarginate e discriminate devono sperimentare un cambiamento culturale di ampia portata."

Come superare la sindrome dell'impostore
Poiché non si tratta di una patologia, non esiste una "cura", ma un percorso per superare la sindrome dell'impostore. Il primo passo è riconoscere le dinamiche scatenanti e prendere consapevolezza di come questi pensieri influenzano la nostra vita. Da qui, è possibile iniziare a costruire una narrazione diversa di sé.
Il percorso è unico per ogni persona, perché ognuno di noi ha una storia e delle peculiarità che fanno la differenza. Vediamo però alcune strategie che possono aiutare a uscire da questo schema di pensiero.
Riconoscere la sindrome dell'impostore
Il primo passo fondamentale è prendere consapevolezza di questi schemi di pensiero. Riconoscerli permette di fare un passo indietro, osservarli senza giudizio e iniziare a scardinare la convinzione di essere un bluff. Lavorare su di sé e sulla propria crescita personale è la chiave. Ecco alcune strategie pratiche che possono essere d'aiuto:
- Cercare una valutazione oggettiva: quando senti che la svalutazione prende il sopravvento, prova a cercare un parere obiettivo da una persona di fiducia per avere una prospettiva più equilibrata.
- Tenere traccia dei successi: può essere utile mettere per iscritto tutti i propri successi, anche i più piccoli, insieme ai complimenti ricevuti. Rileggerli nei momenti di dubbio aiuta a contrastare la narrazione negativa.
- Condividere la propria esperienza: entrare in contatto con persone che vivono la stessa condizione e scambiare opinioni e sensazioni può essere incredibilmente liberatorio. Scoprire di non essere soli riduce il senso di isolamento e vergogna.
Quando la sindrome dell'impostore è accompagnata da forte ansia, umore deflesso o un'insicurezza patologica che limita la vita di tutti i giorni, un percorso psicologico può offrire un aiuto concreto. Il supporto di uno psicologo o psicoterapeuta può aiutare a esplorare le origini di questi sentimenti, a riconoscere e modificare gli schemi di pensiero disfunzionali e a costruire un'immagine di sé più stabile e realistica.
Un altro metodo che sembra essersi rivelato efficace è quello di utilizzare gli strumenti del coaching psicologico, come sottolineato da una ricerca del 2020 che ha lavorato con un approccio "caratterizzato dal supporto sistematico allo sviluppo di convinzioni in un sé lavorativo auto-efficace, corrispondente ad una mentalità di crescita".
Il team di studiosi ha concluso che "l'intervento di coaching può essere visto come un modo efficace per ridurre i punteggi IP (impostor phenomenon). Pertanto, concludiamo che favorire un cambiamento di mentalità nel ridurre la paura di valutazioni negative mediante un intervento di coaching è effettivamente un modo efficace per ridurre le espressioni della PI".

Esiste un test per diagnosticare la sindrome dell'impostore?
Non esistono test diagnostici ufficiali, dato che non si tratta di una patologia. Esistono però delle scale di autovalutazione, come la Clance Impostor Phenomenon Scale (CIPS), sviluppata dalla Dott.ssa Pauline Clance, che possono aiutare a misurare l'intensità con cui si vivono questi sentimenti e a prendere maggiore consapevolezza del problema.
Sindrome dell’impostore: libri per approfondire
Il primo libro sulla sindrome dell'impostore che suggeriamo è quello di Pauline Rose Clance, citata all’inizio di questo articolo: The Impostor Phenomenon: Overcoming The Fear That Haunts Your Success. A questo testo aggiungiamo:
- Pensavo di essere io... invece è la Sindrome dell'Impostore. Come trasformare il senso di inadeguatezza nel nostro migliore alleato, F. Di Stefano, Vallardi Editore
- E se poi mi scoprono? Noi donne e la sindrome dell'impostore, E. Cadoche, A. de Montarlot, Longanesi
- La sindrome dell'impostore. Perché pensi che gli altri ti sopravvalutino, S. Mann, Feltrinelli.
Superare la sindrome dell'impostore è possibile
Sentirsi un impostore è un'esperienza più comune di quanto si pensi e non definisce il tuo valore o le tue capacità. È un insieme di pensieri e paure che possono essere compresi e gestiti. Riconoscere questi schemi è il primo, coraggioso passo verso il cambiamento.
Ricorda che non devi affrontare questo percorso da solo. Se senti che questi pensieri stanno limitando la tua vita e il tuo benessere, parlarne con un professionista può fare la differenza. Un terapeuta può aiutarti a esplorare le radici di queste insicurezze e a costruire una visione di te più realistica e compassionevole. Se senti il bisogno di un supporto, puoi iniziare il questionario per trovare il tuo psicologo online e iniziare un percorso verso il benessere.