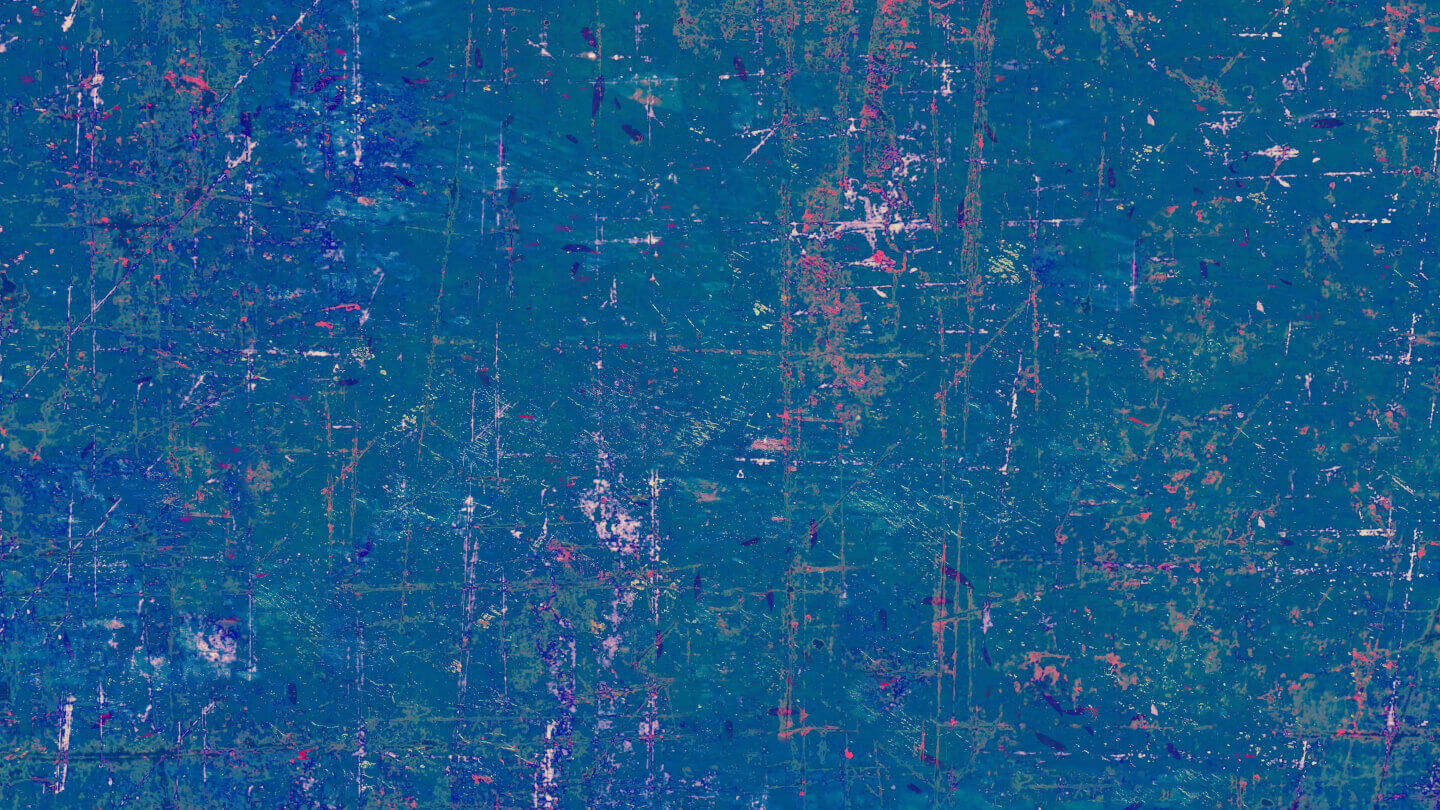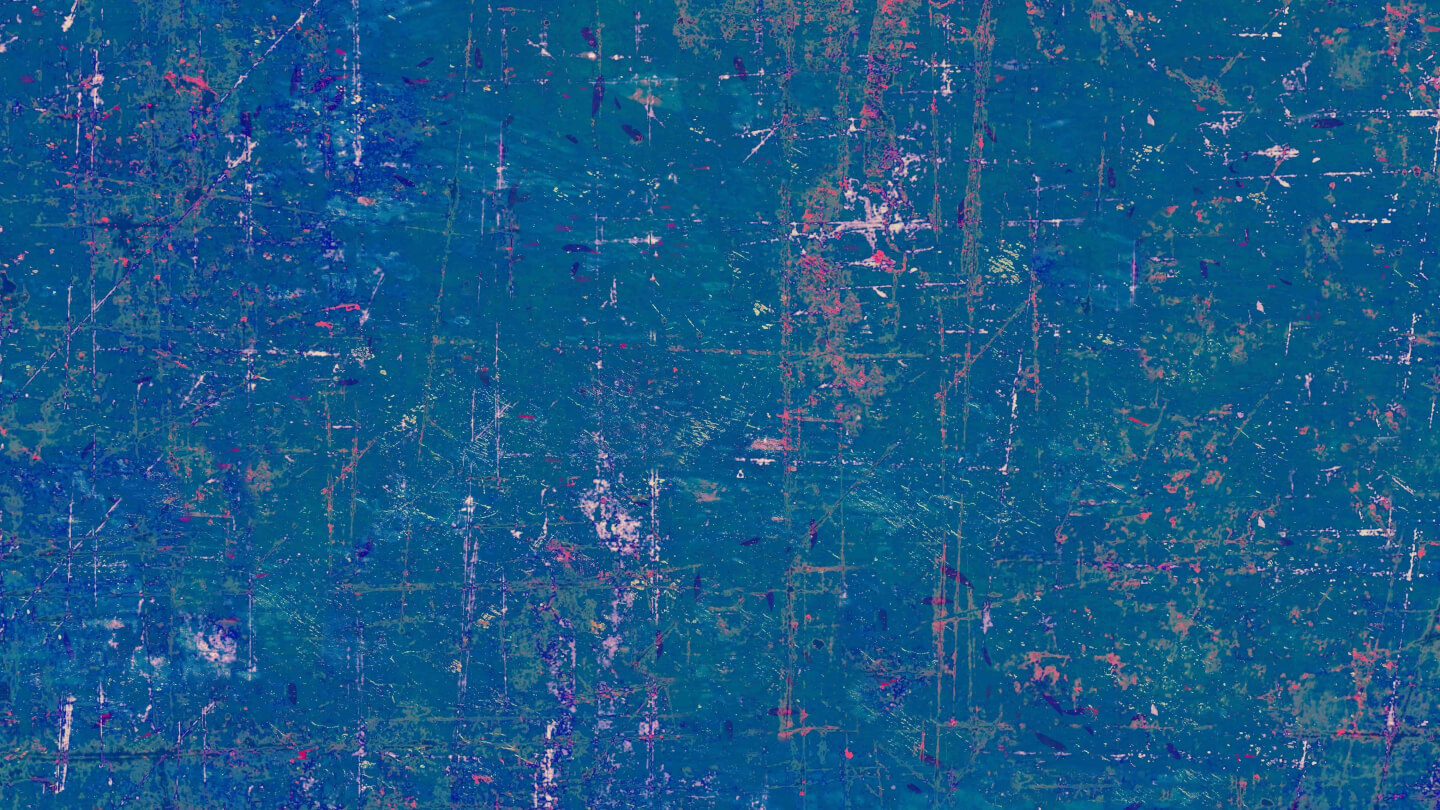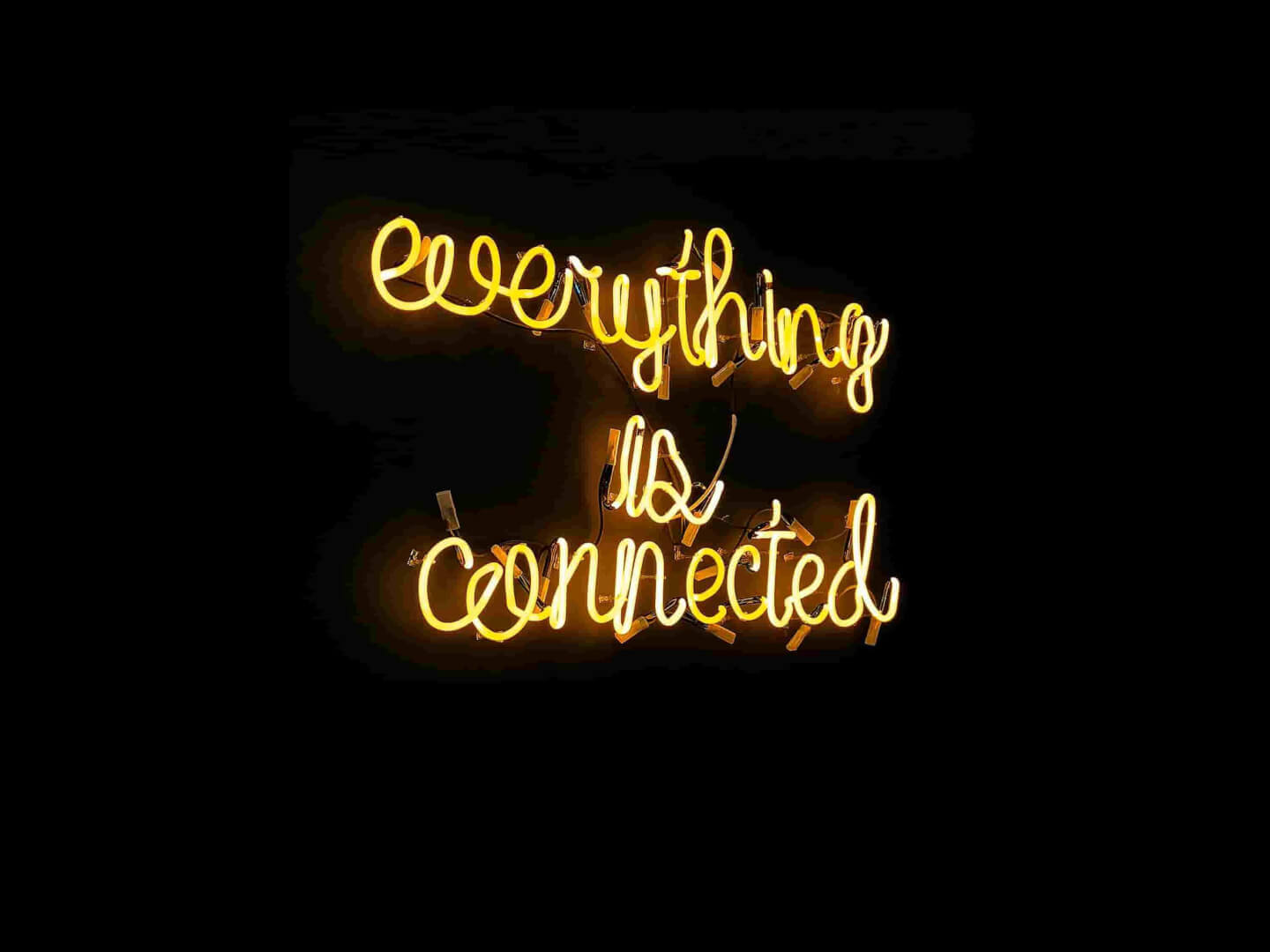Nelle condotte di autolesionismo, il corpo diventa il “teatro” in cui si manifestano le dinamiche psichiche interne. Non è mai un oggetto separato dalla persona, ma rappresenta il tramite attraverso cui si realizza il senso della propria esistenza. Sia che si tratti di un corpo disincarnato, come accade in alcuni adolescenti, sia che sia un corpo agito, come nel disturbo borderline di personalità, il corpo racconta sempre qualcosa di profondo.
Il corpo nell'autolesionismo
Il corpo è costantemente aperto al mondo e alla significazione sociale. È coinvolto nei processi di definizione identitaria e, allo stesso tempo, nello scambio con l’altro, in un percorso evolutivo che può portare a rigettare come estraneo sia ciò che è diverso da Sé sia, paradossalmente, ciò che è più proprio. La ferita si colloca in questa frattura e trasforma la pelle in un veicolo per esprimere la propria esperienza e le emozioni, rendendole visibili a sé stessi e agli altri. Si tratta quindi di un atto comunicativo: in terapia è importante comprendere cosa questa ferita vuole comunicare, per provare a interpretarla insieme alla persona.
Le forme di autolesionismo
Attraverso le condotte autolesioniste, la persona cerca di modulare l’intensità delle proprie esperienze emotive. Come sostiene l’antropologo Le Breton, chi mette in atto questi comportamenti compie una sorta di rito ordalico, cioè una prova dolorosa in cui sfida la morte: il corpo diventa così la superficie su cui incidere il proprio dolore. Lo psichiatra Armando Favazza, nel suo testo Corpi sotto assedio: l’automutilazione nella cultura e in psichiatria, distingue tre forme di autolesionismo:
- Autolesionismo maggiore: comprende gesti poco frequenti ma gravi, come l’evirazione o l’autoamputazione;
- Autolesionismo stereotipato: comprende azioni ripetitive come battersi, percuotersi o graffiarsi;
- Autolesionismo superficiale/moderato: è la forma più diffusa, in cui rientrano condotte come la tricotillomania (strapparsi i capelli) o scorticarsi la pelle.

Classificazione dettagliata delle tipologie di autolesionismo
Oltre alla distinzione tra autolesionismo maggiore, stereotipato e superficiale/moderato proposta da Favazza, la letteratura clinica (Favazza & Rosenthal, 1993) suggerisce una classificazione più articolata, utile per comprendere la varietà delle manifestazioni:
- Autolesionismo non suicidario (NSSI): comprende atti come tagli, bruciature, graffi o colpi inferti a se stessi, messi in atto senza l’intenzione di togliersi la vita. Può essere la forma più diffusa tra adolescenti e giovani adulti.
- Autolesionismo impulsivo: caratterizzato da episodi improvvisi e non pianificati, spesso in risposta a emozioni intense o situazioni di stress.
- Autolesionismo compulsivo: si manifesta con gesti ripetitivi e ritualizzati, come strapparsi i capelli (tricotillomania) o mordicchiarsi la pelle, spesso associati a disturbi ossessivo-compulsivi.
- Autolesionismo para-suicidario: include comportamenti che, pur non avendo un intento suicidario diretto, possono mettere seriamente a rischio la salute della persona.
Questa classificazione permette di individuare strategie di intervento più specifiche e di comprendere meglio le motivazioni sottostanti ai diversi comportamenti.
Dati epidemiologici e incidenza dell’autolesionismo
L’autolesionismo coinvolge soprattutto adolescenti e giovani adulti, con una prevalenza maggiore tra le ragazze. Secondo una revisione sistematica pubblicata su "The Lancet Psychiatry" nel 2022, circa il 17% degli adolescenti nel mondo ha sperimentato almeno un episodio di autolesionismo non suicidario (NSSI) durante la propria vita (Gillies et al., 2022).
In Italia, una ricerca dell’Istituto Superiore di Sanità del 2021 ha evidenziato che 1 adolescente su 5 tra i 14 e i 17 anni ha riferito di aver messo in atto comportamenti autolesionistici almeno una volta. Le ragazze risultano più coinvolte rispetto ai ragazzi, con una percentuale che può arrivare fino al 70% dei casi segnalati nei servizi di salute mentale giovanile.
Questi dati sottolineano l’importanza di riconoscere precocemente i segnali di disagio e di promuovere una cultura di prevenzione e di supporto psicologico.
Criteri diagnostici e classificazione clinica secondo il DSM-5
Il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-5), pubblicato dall’American Psychiatric Association, riconosce l’autolesionismo non suicidario (NSSI) come una condizione che merita attenzione clinica, anche se non è ancora inserita tra i disturbi principali. Secondo il DSM-5, il NSSI si caratterizza per:
- Ripetuti atti intenzionali di danneggiamento del proprio corpo (come tagli, bruciature, graffi), senza intento suicidario, almeno in cinque o più giorni nell’ultimo anno.
- Motivazione principale legata al sollievo da uno stato emotivo negativo, alla risoluzione di difficoltà interpersonali o al desiderio di sentirsi vivi.
- Il comportamento non è socialmente accettato (ad esempio, non rientra in pratiche culturali o religiose).
- Il disagio o la compromissione significativa nelle aree di funzionamento sociale, scolastico o lavorativo.
Questa definizione può aiutare i professionisti a distinguere l’autolesionismo da altri comportamenti e a individuare percorsi di intervento mirati.
Autolesionismo e genere
Le condotte autolesionistiche si manifestano sempre più anche nel virtuale, uno spazio di espressione e condivisione di emozioni, ma anche luogo in cui il disagio può emergere. In questo contesto, si sviluppa una forte identità legata al sintomo: la comunicazione viaggia rapidamente, soprattutto attraverso le immagini, e cicatrici e ferite contribuiscono a marcare un senso di identità sociale. La letteratura evidenzia come l’autolesionismo sia una condotta prevalentemente femminile, diffusa tra le adolescenti e giovani adulte.
L’autolesionismo è donna?
Le ricercatrici D’Agostino, Fabi e Sneider confermano il fenomeno come prevalentemente femminile. La donna:
- riesce a preservare una maggiore integrazione tra corpo e mente;
- è spesso esclusa dalla società razionale;
- è chiamata ad adempiere a diversi ruoli nel contesto familiare.
Il corpo, così, diventa un mezzo di espressione della sofferenza, mentre gli uomini tendono più facilmente a separare la realtà interna da quella esterna. In alcuni studi dello psichiatra A. Sourander, il genere femminile viene persino considerato un fattore predittivo di condotte autolesioniste in adolescenza, insieme ad altre problematiche come la gestione delle emozioni, dell’aggressività infantile e una situazione familiare disorganizzata.

Consigli pratici per familiari, amici e persone coinvolte
Affrontare l’autolesionismo di una persona cara può essere doloroso e complesso. Tuttavia, il supporto del contesto familiare e sociale è fondamentale per favorire il percorso di guarigione. Ecco alcune strategie utili:
- Ascolto empatico: Offrire uno spazio di ascolto senza giudizio, mostrando comprensione e accoglienza verso la sofferenza espressa.
- Evitare reazioni punitive o colpevolizzanti: Reagire con rabbia o senso di colpa può aumentare il senso di isolamento della persona e rafforzare il comportamento autolesionistico.
- Incoraggiare la comunicazione: Favorire il dialogo aperto sulle emozioni e sulle difficoltà, senza forzare la persona a parlare se non si sente pronta.
- Sostenere la ricerca di aiuto professionale: Accompagnare la persona nella scelta di rivolgersi a uno psicologo o a un servizio specializzato può rappresentare un passo importante verso il benessere.
- Prendersi cura di sé: Anche chi sta vicino a una persona che si autolesiona può sperimentare stress e senso di impotenza. È importante riconoscere i propri limiti e, se necessario, cercare supporto per sé stessi.
Questi consigli possono aiutare a creare un ambiente più sicuro e favorevole al cambiamento, ricordando che il percorso di recupero richiede tempo, pazienza e la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti.
Trattamento e relazione terapeutica
Maurizio Andolfi, psichiatra e psicoterapeuta, nel testo Storie di adolescenza: esperienze di terapia familiare mette in luce il valore peculiare del setting terapeutico familiare nel trattamento di queste condotte al limite. Il sintomo va riletto in chiave relazionale, diventando una porta di accesso al sistema familiare che manifesta la propria difficoltà nel comprendere l’ambivalenza e la complessità di questo periodo di vita. La sfida del terapeuta consiste nel trasformare il “contro” in un incontro.
Ri-direzionare quella rabbia e aggressività può diventare una risorsa preziosa per un terapeuta familiare, perché può aiutare anche i genitori a rivedersi attraverso gli occhi del proprio figlio, che reclama amore e ascolto. Il terapeuta, così, si propone come modello di relazione correttiva e non sostitutiva, permettendo anche alla famiglia di andare oltre il sintomo.
L’adolescente ha un forte bisogno di essere accolto e compreso nella sua sofferenza: l’attenzione al sintomo in chiave relazionale permette di trasformare la ferita dell’autolesionista in una feritoia, uno spazio di nuove possibilità.
In questo percorso di ascolto e di comprensione, può essere utile rivolgersi a uno psicologo che lavora su tematiche legate all’autolesionismo, che possa offrire uno spazio sicuro e non giudicante in cui esplorare il proprio vissuto e intraprendere un cammino di maggiore consapevolezza e benessere.