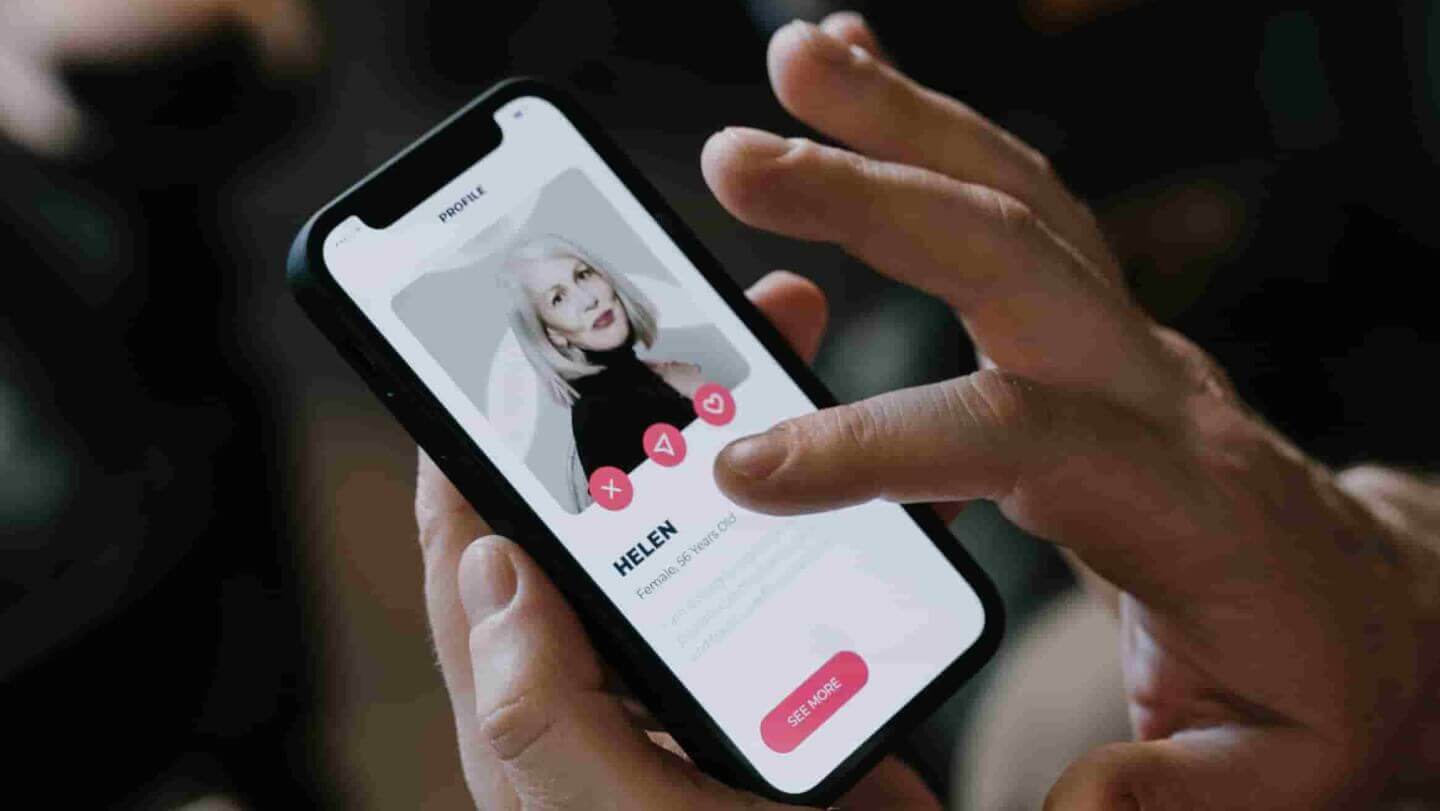Spesso si parla degli effetti negativi del patriarcato sulle donne, soffermandosi su come la società in cui viviamo abbia creato stereotipi e pregiudizi per loro dannosi. In occasione del mese della salute maschile, vogliamo introdurre un approfondimento che faccia luce anche sulle conseguenze negative che stereotipi e ruoli di genere hanno sulle vite degli stessi uomini.
Ad esempio, è ancora diffusa un’ideologia tradizionale che associa virilità e mascolinità con l’idea che gli uomini non possano mostrare le proprie emozioni per non rovinare la loro immagine “da duro”. Questa visione “dell'uomo vero” porta a una concezione di mascolinità, che a lungo andare può risultare dannosa sia per la salute mentale degli uomini che per la società in cui vivono, per l’appunto una mascolinità tossica.
Che cos'è la mascolinità tossica?
La definizione di mascolinità tossica si è evoluta nel tempo. Il termine fu utilizzato per la prima volta dallo psicologo Shepherd Bliss negli anni ’80. Uno studio pubblicato sul Journal of School of Psychology spiega così il significato di mascolinità tossica: «L’insieme di tratti [maschili] socialmente regressivi che servono a favorire il dominio, la svalutazione delle donne, l'omofobia e la violenza insensata». Negli ultimi anni, la ricerca scientifica ha portato allo sviluppo e alla validazione di una scala specifica per misurare la mascolinità tossica, nota come Toxic Masculinity Scale (TMS), che inizialmente comprendeva cinque fattori ma è stata ottimizzata in una versione finale composta da 28 item suddivisi su quattro fattori distinti (Sanders et al., 2024).
Alcuni ricercatori concordano sul fatto che la mascolinità tossica abbia tre caratteristiche principali:
- durezza, ovvero la convinzione che gli uomini dovrebbero essere fisicamente forti, emotivamente insensibili e aggressivi nel comportamento;
- anti femminilità, cioè il rifiuto di tutto ciò che è considerato femminile, come mostrare emozione o chiedere/accettare aiuto;
- potere, ossia la pressione a ottenere potere e status sociale e finanziario per guadagnare il rispetto degli altri.
Secondo i tradizionali valori maschili tossici, un uomo che non fa suoi questi tratti non è considerato un "vero uomo".
Mascolinità egemone e strutture di potere
Il concetto di mascolinità egemone è stato introdotto dalla sociologa Raewyn Connell, docente e ricercatrice, riconosciuta a livello internazionale per descrivere il modello dominante di mascolinità che viene promosso e valorizzato nella società. Secondo Connell, la mascolinità egemone rappresenta l'ideale a cui gli uomini dovrebbero aspirare: forza, controllo delle loro emozioni, successo economico e predominio sulle donne e su altri uomini percepiti come "meno virili".
Questa forma di mascolinità non è solo un insieme di caratteristiche personali, ma è sostenuta da strutture di potere che si riflettono nelle istituzioni, nei media e nelle relazioni sociali. Tali strutture contribuiscono a rendere la mascolinità tossica un modello di riferimento, esercitando pressioni su chiunque si discosti da questi standard. Come sottolinea Connell nel suo libro "Masculinities" (1995), la mascolinità egemone non è la più diffusa tra gli uomini, ma è quella che viene maggiormente premiata e riconosciuta, rafforzando così le disuguaglianze di genere e la marginalizzazione di chi non si conforma.
Da dove viene la mascolinità tossica?
Nella tradizionale costruzione della mascolinità ci sono molti stereotipi che possono portare gli uomini a sviluppare comportamenti tossici. Il significato di mascolinità è strettamente legato alla forza, definita come la "capacità di sopportare problemi e avversità".

Bambini e adolescenti crescono sentendosi obbligati a essere forti di fronte ai problemi e alle avversità, contenendo le proprie emozioni. Gli vengono insegnati “giochi da maschio”, e vengono abituati ad essere piccoli ometti che devono fare gli “uomini di casa” o proteggere le sorelle. Chi assume atteggiamenti contrari a questi stereotipi di genere, inevitabilmente diventa la pecora nera della famiglia.
Frasi come "i veri uomini non piangono" o “non fare la femminuccia” possono influire seriamente sulla salute mentale di bambini, ragazzi e uomini e, senza dubbio, anche su coloro che li circondano. Così, gli uomini cresciuti nella società patriarcale si identificano con la capacità di dominio e possono credere che esercitare il proprio potere sulle donne non sia solo una libertà ma un diritto. Queste convinzioni potrebbero a lungo andare portare alla spirale della violenza nella coppia che in alcuni casi, come ci insegna la cronaca odierna, sfocia in femminicidio.
Il rifiuto per tutto ciò che viene considerato femminile, e quindi ritenuto debole, può essere anche la causa di comportamenti e ideali misogini e omofobi. La mascolinità tossica non solo vede le donne come inferiori, ma ripudia anche tutti quegli uomini che non rientrano nei cliché della mascolinità e che spesso fanno fatica ad accettare la propria omosessualità. Inoltre, le comunità online legate alla mascolinità tossica presentano parallelismi con gruppi estremisti, suggerendo che possono rappresentare un rischio di radicalizzazione per gli adolescenti maschi (Gilmour, 2025).
Pressioni sociali e culturali: perché si può aderire ai modelli tossici
Molti uomini possono sentirsi spinti ad aderire a modelli di mascolinità tossica a causa delle forti pressioni sociali e culturali che iniziano fin dall'infanzia. Secondo Michael Kimmel, sociologo e tra i massimi esperti di studi sulla mascolinità, la società trasmette costantemente messaggi su cosa significhi essere un "vero uomo", spesso attraverso la famiglia, la scuola, i media e i gruppi di pari.
Queste pressioni possono manifestarsi in vari modi:
- il conformismo di gruppo, per esempio, porta molti uomini a temere l’esclusione o il ridicolo se non si adeguano alle aspettative del gruppo, come mostrare durezza o evitare di esprimere vulnerabilità.
- le sanzioni sociali: chi si discosta dai modelli tradizionali rischia di essere etichettato come debole, poco virile o addirittura escluso socialmente.
- i modelli mediatici, attraverso film, pubblicità e sport, che rafforzano l’idea che la forza fisica, il successo e il controllo siano tratti indispensabili per essere rispettati.
È importante sottolineare che le caratteristiche della mascolinità tossica sono associate a una minore disponibilità a intervenire in favore della vittima, quando testimoni di una prevaricazione, suggerendo la necessità di tenerne conto nella progettazione di interventi contro il bullismo (Ingram et al., 2019). Queste dinamiche possono contribuire a interiorizzare comportamenti e convinzioni che, pur essendo dannosi, vengono percepiti come necessari per ottenere approvazione e appartenenza.
L’uomo che non deve chiedere mai: storia di un falso mito
Molti ricordano lo spot degli anni ’90 di un famoso profumo per uomo in cui si vedeva una donna lanciarsi con una certa veemenza sul maschio di turno. La voce narrante affermava: “Per l’uomo che non deve chiedere mai”.

Un po’ come il narcisista che ha un’idea grandiosa di sé e si nutre della costante necessità di essere ammirato, così l’uomo che abbraccia la cultura della mascolinità tossica si alimenta della sua “forza” e “sicurezza”.
Un altro spot di una nota marca di rasoi nel 2019 cambiava la trama classica delle pubblicità di questo tipo, dando una versione inedita della tematica "il meglio di un uomo", combattendo gli stereotipi sessisti e mostrando altri comportamenti maschili come un padre che incoraggia la propria figlia ad assumere sicurezza e forza, oppure un uomo che impedisce all’altro di molestare sessualmente una donna.
Nel caso dello spot Gillette, è interessante parlare della reazione alla pubblicità. Molti spettatori hanno sostenuto che l’azienda stesse accusando tutti gli uomini di essere aggressivi, violenti o poco rispettosi delle donne, benché l’intento dello spot fosse esattamente l’opposto, ovvero invitare coloro che sono sicuri della propria mascolinità positiva a incoraggiare gli altri a comportamenti migliori.
Perché lo spot è stato recepito come un’accusa? Forse perché mostrava sotto una luce negativa un modo di essere uomo che noi siamo abituati a vedere come l’unico possibile.
Mascolinità tossica in psicologia
In psicologia si parla di mascolinità tossica riferendosi all’insieme di comportamenti e atteggiamenti nocivi associati agli uomini, che vengono comunemente visti come segni di virilità o dell’essere un vero uomo e che nei rapporti famigliari possono avere come conseguenza i daddy issues.
Come deve essere un vero uomo? Un vero uomo non piange, non ha bisogno di aiuto, sa farsi rispettare dagli amici e dalla propria compagna. Non seguire un certo codice di comportamento mette in dubbio la virilità maschile e l'immagine che l’uomo dà di sé agli altri.
In che modo la mascolinità tossica influenza se stessi e gli altri?
Gli effetti sulla salute mentale
L’imperativo “devi essere forte”, a cui sono stati educati, spinge molti uomini a chiudersi in se stessi e a non condividere mai le proprie emozioni. Essere “sensibili”, tuttavia, non è solo tipicamente femminile: provare emozioni è umano, e nascondere i propri sentimenti non basta certo a farli scomparire. Inoltre, poiché non è considerato “da uomo forte” chiedere aiuto, molti uomini vivono in silenzio e in solitudine sintomi di disagio psicologico, che possono portare alla depressione e al suicidio, una delle principali cause di morte tra gli uomini in tutto il mondo. Recenti studi hanno inoltre evidenziato che l’uso dei social media, combinato con la pressione della mascolinità tossica, è associato a livelli più elevati di depressione negli uomini (Parent et al., 2019).
Gli effetti sui rapporti con gli altri
Il muro che alcuni uomini costruiscono attorno ai propri sentimenti avvelena il rapporto con gli altri e le relazioni romantiche. In assenza di reciprocità riguardo alle manifestazioni di affetto, molte relazioni sfociano in una relazione tossica oppure finiscono per raffreddarsi, con uno dei partner che crede che l'altra persona non provi lo stesso.
Qualcosa di simile accade con le relazioni familiari e le amicizie. Da genitori che non hanno mai saputo esprimere l’amore che provavano per i propri figli, perché nessuno aveva dato loro le chiavi per manifestare le proprie emozioni, ad amici che perdono il contatto perché non sono in grado di mostrare cosa significasse per loro quell’amicizia, la mascolinità tossica può portare alla solitudine di molti.

Problemi sessuali
La mascolinità tossica è strettamente correlata al culto del fallo e rappresenta una delle forme dannose di mascolinità, le quali sono associate a esiti negativi per la salute sessuale e riproduttiva sia degli uomini che delle donne. È una credenza diffusa che il potere dell’uomo si manifesti esclusivamente nella sua capacità riproduttiva e, di conseguenza, gli uomini non dovrebbero frenare i loro impulsi sessuali. Questo problema si articola in due aspetti distinti:
- Gli uomini sono spinti a mantenere una vita sessuale attiva in ogni momento, a vivere intorno alla loro sessualità e ad esprimerla apertamente. Le elevate aspettative sull'attività sessuale degli uomini portano molti di loro a sviluppare problemi come la disfunzione erettile (Fonte: https://www.unobravo.com/post/le-disfunzioni-erettili-cause-e-trattamento).
- Alcuni uomini crescono credendo che il sesso sia un desiderio che le donne hanno l'obbligo di soddisfare. Vedere le donne più come un oggetto del desiderio che come persone può portare a non avere a mente l’importanza del consenso della partner (Fonte: https://www.unobravo.com/post/consenso-sessuale) e a una moltitudine di comportamenti problematici come catcalling (Fonte: https://www.unobravo.com/post/catcalling-la-sottile-differenza-tra-apprezzamento-e-molestia), o, nei casi più gravi a molestie sessuali, stupri e violenza di genere.
Conseguenze sistemiche della mascolinità tossica
Oltre agli effetti individuali, la mascolinità tossica può avere un impatto profondo anche a livello sociale e sistemico. Le principali conseguenze sistemiche includono:
- Aumento della violenza: la pressione a dimostrare forza e dominio può contribuire a comportamenti aggressivi, sia nelle relazioni personali che nella società, ed è spesso associata a tassi più elevati di violenza domestica e di genere.
- Ostacoli all'uguaglianza di genere: la mascolinità tossica rafforza ruoli di genere rigidi, rendendo più difficile il raggiungimento di una reale parità tra uomini e donne.
- Costi economici e sanitari: secondo uno studio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2021, la promozione di modelli maschili tossici è associata a un maggiore rischio di incidenti, abuso di sostanze e minore propensione a cercare aiuto medico, fattori che possono avere conseguenze negative per la salute pubblica e i sistemi sanitari.
Questi effetti dimostrano come la mascolinità tossica non sia solo un problema individuale, ma una questione che riguarda l'intera collettività e richiede un cambiamento culturale profondo.
Prevenire la mascolinità tossica
È possibile sbarazzarsi del concetto di mascolinità tossica? La mascolinità non è per natura tossica. Ciò che è tossico è la cultura dominante della mascolinità: il rigido insieme di aspettative, percezioni e definizioni di comportamento "virile”.
Fortunatamente negli ultimi vent’anni sono stati fatti passi enormi in questo senso. Dall’uomo incarnato da Brad Pitt in “Fight Club” ad Harry Styles, da Achille Lauro fino ai Maneskin: i modelli maschili di riferimento stanno cambiando. Si stanno decostruendo le caratteristiche dell’uomo virile, l’uomo che in Fight Club si mostrava duro e privo di sentimenti cede il posto a un nuovo modello.
Non più l’uomo che non deve chiedere mai, ma un uomo che si veste come gli pare e che si lascia andare alle emozioni verso una nuova mascolinità: amorevole, aperta, empatica, egualitaria e non violenta.
Cercare di replicare modelli culturali che propongono divisioni rigide di specifiche categorie umane, e da cui derivano omofobia e misoginia, è un errore, perché la realizzazione di noi stessi avviene sempre tramite un processo di mediazione, di interpretazione. In questo processo non c’è più spazio per il pregiudizio.
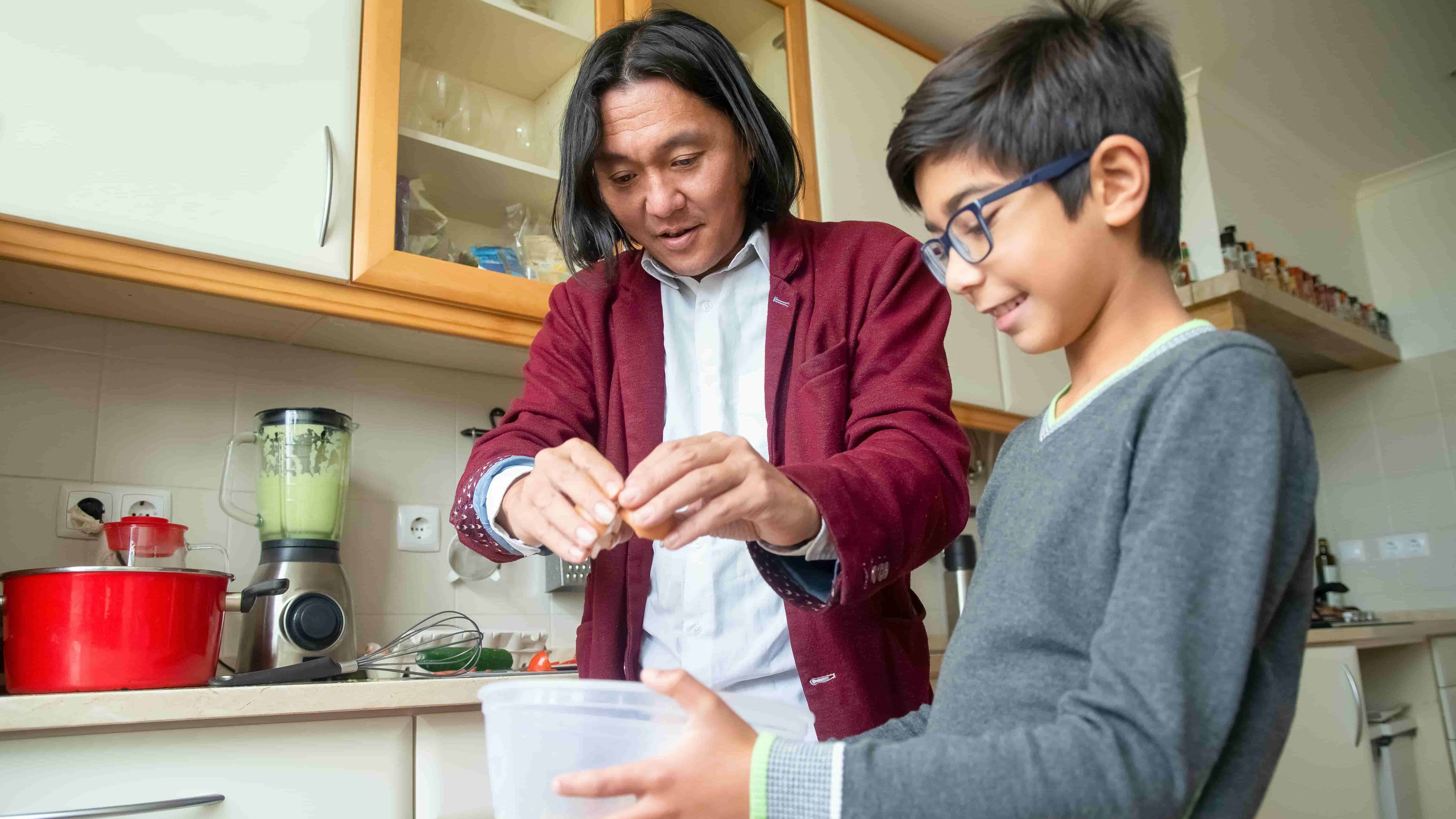
Lasciarsi alle spalle la mascolinità tossica inizia con la ridefinizione di cosa significa essere un uomo. Ogni persona dovrebbe aspirare a trovare una sana definizione della propria individualità e lavorare per raggiungerla.
Per prevenire la mascolinità tossica ci sono alcune cose che tutti possiamo fare: dall'iniziare a parlare dei sentimenti degli uomini in modo naturale, allo smettere di normalizzare la violenza ed educare allo stesso modo ragazzi e ragazze, insegnando loro a prendersi cura di se stessi e degli altri.
Libri sulla mascolinità tossica
- “Uomini duri. Il lato oscuro della mascolinità” di Maria Giuseppina Pacilli.
- “The Myth of Masculinity” di Joseph Pleck.
- “Psicosociologia del maschilismo” di Chiara Volpato.
- “La genesi del maschile. Modelli culturali di virilità” di David Gilmore.
- “Dovremmo essere tutti femministi” di Chimamanda Ngozi Adichie.
Oltre ai libri consigliamo anche la visione del documentario su Netflix “The mask you live in” con le testimonianze di ragazzi e uomini, che a un certo punto della loro vita hanno percepito talmente forte la pressione sociale da non riuscire più a capire cosa erano e cosa volevano essere.
Bambini cresciuti con l’idea che “femminuccia” sia la peggiore offesa possibile; ragazzini incapaci di riconoscere i propri sentimenti; uomini convinti che la loro identità si basi sulle conquiste e i successi, e che trattano le donne come mezzo per dimostrare la loro virilità... Tutti alla fine hanno dovuto accettare che essere uomo va ben oltre la definizione di mascolinità tossica.
Dati e statistiche sulla mascolinità tossica
Per comprendere l'impatto della mascolinità tossica nella società, può essere utile considerare alcuni dati recenti. Secondo una ricerca dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2021, gli uomini rappresentano circa il 75% dei suicidi a livello globale, un dato che molti esperti collegano anche alla difficoltà di esprimere emozioni e chiedere aiuto, spesso associata ai modelli maschili tossici.
In Italia, uno studio dell'Istituto Superiore di Sanità del 2022 ha evidenziato che il 60% degli uomini intervistati dichiara di aver sentito almeno una volta nella vita la pressione a "non mostrare debolezza" o a "non chiedere aiuto". Inoltre, secondo il rapporto ISTAT 2023 sulla violenza di genere, il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni ha subito una qualche forma di violenza fisica o sessuale, fenomeno spesso legato a dinamiche di potere e controllo riconducibili alla mascolinità tossica.
Questi numeri sottolineano quanto sia urgente promuovere una riflessione collettiva e interventi concreti per superare i modelli dannosi di mascolinità.
Scegliere di cambiare: il primo passo verso una mascolinità più funzionale
Riconoscere il peso degli stereotipi e delle pressioni legate alla mascolinità può essere già un atto di coraggio. Se senti che questi modelli ti stanno limitando, ti fanno sentire solo o ti impediscono di vivere pienamente le tue emozioni, sappi che non sei obbligato ad affrontare tutto da solo. Un percorso psicologico può aiutarti a riscoprire chi sei davvero, contribuendo a liberarti dai condizionamenti e a costruire relazioni più autentiche con te stesso e con gli altri. Da Unobravo puoi trovare uno psicologo che ti accompagni in questo viaggio di consapevolezza e cambiamento, in modo sicuro e rispettoso della tua unicità. Se vuoi iniziare a prenderti cura di te, inizia il questionario per trovare il tuo psicologo online: il primo passo verso una nuova idea di mascolinità parte da qui.